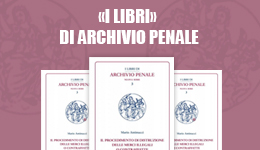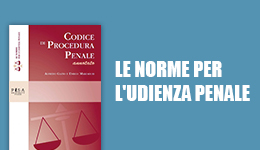Con la sentenza n. 7 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato:
1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, co. 2, c.c., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato;
2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, co. 1, c.c., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo».
La Consulta ha stabilito che la previsione in termini obbligatori della confisca dei beni utilizzati per commettere un reato societario (art. 2641, co. 1, c.c.) e della confisca di una somma di denaro o beni di valore equivalente (art. 2641, co. 2, c.c.) è suscettibile di produrre risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati ed è pertanto incompatibile con i parametri sui quali si fonda il principio di proporzionalità della pena, nella sua dimensione interna e sovranazionale.
Le questioni sono state sottoposte alla Corte costituzionale dalla Corte di cassazione, sezione quinta penale, nell’ambito della vicenda processuale relativa alla crisi della Banca Popolare di Vicenza.
In primo grado, il Tribunale di Vicenza aveva disposto a carico di quattro imputati la confisca della somma di 963 milioni di euro, calcolata con riferimento all’importo complessivo che sarebbe stato utilizzato dalla banca presso la quale gli imputati operavano, per commettere una pluralità di reati di aggiotaggio societario e ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della Banca centrale europea. La Corte d’appello di Venezia aveva poi confermato in parte la responsabilità degli imputati, ma aveva revocato la confisca, disapplicando, nel caso concreto, l’art. 2641 c.c. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia aveva quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente disapplicato l’art. 2641 c.c. La Corte di cassazione, a fronte della possibile alternativa rappresentata dalla disapplicazione della norma interna contrastante con l’art. 49, § 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), ha scelto invece di sollevare questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2641, co. 1 e 2, c.c., censurandolo «nella parte in cui assoggetta a confisca per equivalente anche i beni utilizzati per commettere il reato».
La Corte costituzionale ha ritenuto rilevanti tutte le questioni prospettate dalla Sezione rimettente, precisando che la censura, pur se testualmente formulata in relazione al co. 1 e al co. 2 dell’art. 2641 c.c., investe in realtà soltanto la disposizione di cui al co. 2, concernente la confisca per equivalente dei beni strumentali. Inoltre, la Corte ha osservato che, nel caso in esame, alla luce dell’art. 51 CDFUE, è applicabile l’art. 49, § 3, CDFUE, con la conseguente possibilità di evocare anche questa disposizione come parametro interposto nella questione di legittimità costituzionale.
Nel merito, la Consulta ha reputato fondate le censure relative all’art. 2641, co. 2, c.c., formulate dal rimettente in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., nonché agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 49, § 3, CDFUE, restando assorbiti gli ulteriori parametri evocati dal giudice a quo, in riferimento ai principi costituzionali, convenzionali e unionali in materia di tutela del diritto di proprietà.
La Corte ha, anzitutto, affermato che la confisca, diretta e per equivalente, dei beni utilizzati per commettere uno dei reati societari disciplinati dal Titolo XI, Libro V del codice civile ha natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale e, in quanto tale, deve rispettare il principio di proporzionalità della pena. Questo principio vieta che l’entità dell’ablazione patrimoniale risulti sproporzionata tanto rispetto alla gravità del reato, quanto alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto colpito dalla pena. Ad avviso della Consulta, la disposizione censurata, là dove configura in termini di obbligatorietà la confisca delle somme di denaro o dei beni di valore equivalente ai beni strumentali, è strutturalmente suscettibile di produrre risultati sanzionatori in concreto sproporzionati, perché vincola il giudice ad applicare la misura anche quando essa risulti esorbitante rispetto alla capacità dell’interessato di far fronte al pagamento richiesto. Queste affermazioni – ha osservato il Giudice delle leggi – trovano conferma nel diritto comparato e nel diritto dell’Unione europea, in cui la previsione della confisca dei beni strumentali è di regola subordinata a una valutazione di compatibilità della sua inflizione con il principio di proporzionalità.
Pertanto, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il censurato art. 2641, co. 2, c.c., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato.
Inoltre, la Consulta ha esteso in via consequenziale la dichiarazione di illegittimità costituzionale alla previsione di cui all’art. 2641, co. 1, c.c., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo», poiché il vulnus riscontrato investe – a parere della Corte – per le stesse ragioni anche la disciplina della confisca diretta dei beni utilizzati per commettere il reato.
Il Giudice delle leggi non ha ritenuto di intervenire con una pronuncia manipolativa “sostitutiva” della sanzione censurata con altra conforme a Costituzione, in quanto la presente pronuncia ablativa non crea alcun intollerabile vuoto di tutela degli interessi protetti dalle norme penalmente sanzionate. Spetterà, dunque, al legislatore stabilire se introdurre una nuova disciplina della confisca dei beni strumentali e delle somme di valore equivalente, in modo da assicurare il pieno rispetto del principio di proporzionalità.
Nell’ambito dell’attuale normativa in materia di confisca – ha ricordato la Corte – resta invece ferma la confisca obbligatoria del profitto, diretta o per equivalente, a carico di qualunque persona, fisica o giuridica, che risulti avere effettivamente conseguito le utilità derivanti dal reato. Resta inalterata, infine, la facoltà del giudice di disporre, ai sensi dell’art. 240 c.p., la confisca diretta delle «cose che servirono a commettere il reato».