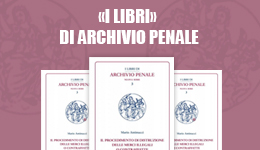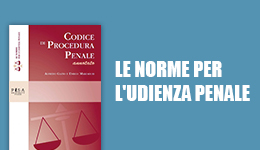Con la sentenza n. 24 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 27, co. 3, Cost., dell’art. 30-ter, co. 5, ord. penit., ove prevede che «[n]ei confronti dei soggetti che durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione [di permessi premio] è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto».
Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato, in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 30-ter, co. 5, ord. penit., in riferimento agli artt. 3, 27, co. 2 e 3, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 48 CDFUE, ritenendo che la preclusione biennale alla concessione di permessi premio stabilita dalla disposizione censurata sia incompatibile, tra l’altro, con la presunzione di innocenza e con il principio della finalità rieducativa della pena.
La Consulta ha anzitutto evidenziato che un’analoga questione era stata ritenuta non fondata nella sentenza n. 296 del 1997. Rilevato che il tendenziale rispetto dei precedenti è condizione essenziale per l’autorevolezza delle proprie decisioni, la Corte ha tuttavia rammentato come sia possibile rimeditare i propri orientamenti allorché vi siano ragioni di particolare cogenza che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate, ad esempio quando esse non siano più conciliabili con il successivo sviluppo della giurisprudenza costituzionale o di quella delle Corti europee (v. sent. cost. n. 203 del 2024). Perciò, la Corte ha verificato se vi fossero ragioni tali da indurla a rimeditare la decisione del 1997, tenendo conto della successiva evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale.
Con riguardo alla presunzione di innocenza, le conclusioni cui era giunta la pronuncia n. 296 del 1997 – per la quale la presunzione di non colpevolezza sarebbe stata legata soltanto al fatto di reato per cui è stata elevata l’imputazione – risultano oggi incoerenti con le declinazioni medio tempore conferite alla presunzione di innocenza dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, dai recenti sviluppi del diritto dell’Unione europea e dalla stessa Corte costituzionale. Gli effetti della presunzione di non colpevolezza non si esauriscono, come si riteneva alcuni decenni fa, all’interno del singolo procedimento penale relativo alla possibile responsabilità per il reato addebitato all’imputato, ma implicano un generale divieto di considerare l’imputato colpevole del reato anche in qualsiasi altro procedimento giudiziario, sino a che la colpevolezza non sia stata accertata in via definitiva.
Pertanto, una disposizione che, come quella censurata, obbliga il magistrato di sorveglianza all’adozione di un provvedimento negativo a carico dell’interessato, per il solo fatto che questi sia stato imputato di un reato da parte del pubblico ministero, agli effetti pratici vincola il giudice a “presumere colpevole” l’imputato. Essa – ha precisato la Corte – sottrae al magistrato di sorveglianza ogni margine di autonomo apprezzamento sulla reale consistenza della notitia criminis e, soprattutto, gli impedisce di ascoltare l’imputato e il suo difensore, nonché di tenere conto delle loro deduzioni, con conseguente, indiretto, vulnus allo stesso diritto di difesa dell’interessato, legato a doppio filo alla presunzione di innocenza.
Per quanto concerne la funzione rieducativa della pena, la Consulta ha ricordato come, nel suo precedente del 1997, l’automatismo in questione fosse stato ritenuto tale da superare lo scrutinio di legittimità costituzionale: la preclusione sarebbe, infatti, stata «inquadrata nel presupposto di quella regolare condotta del condannato che è essenziale per la concedibilità di permessi premio». Ad avviso della Corte, oggi tali affermazioni non sono più sostenibili.
Infatti, la giurisprudenza costituzionale successiva al 1997 ha confermato la tendenziale illegittimità costituzionale degli automatismi in materia di revoca o preclusione dei benefici e delle misure alternative, conseguenti alla commissione di nuovi reati da parte del condannato (in quest’ottica, sent. cost. n. 189 del 2010; in generale, in favore della esclusione di rigidi automatismi che impediscono al giudice qualsiasi verifica sul concreto percorso compiuto dal condannato, v. sent. cost. n. 436 del 1999; n. 257 del 2006; n. 149 del 2018; n. 253 del 2019; n. 56 del 2021). L’automatismo preclusivo stabilito dalla norma censurata – ha concluso la Corte – risulta incompatibile con la necessaria finalità rieducativa della pena, poiché azzera in capo al giudice della sorveglianza ogni margine di valutazione circa il significato concreto del fatto in relazione al percorso trattamentale intrapreso dal condannato e alla sua residua pericolosità sociale. Dunque, in presenza di una imputazione formulata da un pubblico ministero o di una decisione giudiziaria non definitiva o anche in presenza di una condanna definitiva del richiedente, il rispetto del principio rieducativo esige che il magistrato di sorveglianza possa sempre liberamente valutare il concreto rilievo del fatto ai fini della specifica decisione a lui affidata, tenendo conto dei contributi provenienti dalla difesa.
Infine, la Corte ha chiarito come gli argomenti da ultimo esposti in motivazione e, cioè, quelli relativi al contrasto dell’art. 30-ter, co. 5, ord. penit. con la funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27, co. 3, Cost. comportino, già di per sé, la caducazione dell’intera disposizione, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure (compresa quella sollevata in riferimento all’art. 27, co. 2, Cost.) relative al frammento della disposizione concernente la posizione di chi sia soltanto imputato della commissione di un nuovo reato durante l’esecuzione della pena. Pertanto, l’art. 30-ter, co. 5, ord. penit. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella sua interezza.