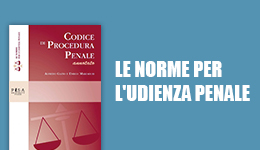La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, co. 1 e 3, e 9, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, co. 2, l. 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, co. 2, e 27, Cost., dal Tribunale ordinario di Varese: dell’art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 3, co. 6, del medesimo D.Lgs. n. 8 del 2016, ai fatti di cui all’art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, anche se commessi prima dell’entrata in vigore del decreto che ne ha disposto la trasformazione in illeciti amministrativi; dell’art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevede che, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile non possa essere superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato; dell’art. 9, D.Lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui impone al giudice penale la trasmissione all’autorità amministrativa, competente ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria, degli atti relativi ai procedimenti penali riguardanti reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato, alla medesima data, risulti prescritto o estinto per altra causa. Oggetto delle questioni sono state, dunque, alcune disposizioni del D.Lgs. n. 8 del 2016, che, in attuazione della delega contenuta nella l. n. 67 del 2014, ha provveduto a sostituire con sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni amministrative accessorie le pene previste per una serie di reati. Si è stabilita, tra l’altro, la trasformazione in illecito amministrativo del delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, laddove, come nel caso di specie, l’importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 per ogni annualità. La condotta depenalizzata è ora punita con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000. Tutte le questioni sono state sollevate per contrasto con i principi di legalità e irretroattività della pena, di cui all’art. 25, co. 2, Cost., con il principio per cui la sanzione afflittiva deve tendere alla rieducazione del condannato e con il principio di colpevolezza, di cui all’art. 27 Cost., nonché con il principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost. Il giudice a quo ha mosso le censure aderendo alla tesi secondo cui il principio di irretroattività di cui all’art. 25, co. 2, Cost. trova applicazione esclusivamente per le norme penali e le pene da queste contemplate; ed ha affermato che, per le sanzioni amministrative, la stessa regola può invece essere derogata, in quanto prevista da una legge ordinaria (l’art. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»). Richiamando la giurisprudenza della Corte EDU, il rimettente ha sostenuto, tuttavia, che le nozioni di «sanzione penale» e di «sanzione amministrativa» non possono essere desunte, semplicemente, dal nomen iuris utilizzato dal legislatore, ma devono essere ricavate tenuto conto delle finalità e della portata del precetto sanzionatorio di volta in volta contemplato, alla luce di quegli indici (cosiddetti criteri Engel) che la Corte EDU ha elaborato in relazione all’art. 7, CEDU. Nel caso di specie, secondo il giudice a quo, la sanzione sarebbe solo formalmente amministrativa, in quanto, per la sua elevata afflittività nei confronti del condannato, perseguirebbe uno scopo chiaramente repressivo e preventivo, piuttosto che soltanto riparatorio, dovendosi considerare, così, sostanzialmente di natura penale. Da ciò deriverebbe la necessaria applicazione dei principi di legalità e di irretroattività delle sanzioni penali, con i quali contrasterebbe la retroattività – prevista dalle disposizioni censurate – della sanzione introdotta dal D.Lgs. n. 8 del 2016. La Consulta ha rilevato come lo scopo perseguito dal giudice rimettente finisca per risultare contraddittorio rispetto alle sue stesse premesse e che i passaggi motivazionali dell’ordinanza di rimessione si allontanano alquanto dalle indicazioni ricavabili dalla costante giurisprudenza costituzionale, a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007. Infatti, il giudice comune, verificata l’impraticabilità di una interpretazione della legislazione italiana in senso convenzionalmente conforme, e non potendo disapplicare la norma interna, deve sollevare questione di legittimità costituzionale della medesima norma interna, per violazione del parametro costituzionale di cui all’art. 117, co. 1, Cost. Il rimettente, invece, prende atto, in primo luogo, del tenore testuale di una legge nazionale alla quale egli stesso riconosce esplicitamente di non poter riferire il principio costituzionale di irretroattività e utilizza i criteri Engel, sia per sottolineare la “vera” natura della sanzione, sia per dimostrare l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 25, co. 2, Cost., della disposizione censurata. Egli, peraltro, non ricorre ai criteri Engel per estendere in via interpretativa alla sanzione formalmente amministrativa le sole garanzie convenzionali che la CEDU riserva alla materia “sostanzialmente penale”, ovvero ai fini di sollevare una questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge per violazione dell’art. 117, co. 1, Cost. Il rimettente segue un altro percorso, intrinsecamente contraddittorio, tendente a ri-trasformare in penale una sanzione espressamente qualificata come amministrativa dal legislatore nazionale, consentendo l’invocazione dei parametri costituzionali interni, dallo stesso rimettente riferiti alla sola pena in senso stretto. In tal modo – prosegue la Corte – il giudice a quo ha inteso ottenere l’allargamento dell’area di ciò che è penalmente rilevante: ma nella sentenza cost. n. 49 del 2015 si è già esclusa la correttezza dell’assunto secondo cui l’illecito amministrativo, che il legislatore distingue con ampia discrezionalità dal reato, appena sia tale da corrispondere, in forza della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ai criteri Engel di qualificazione della “pena”, subirebbe l’attrazione del diritto penale dello Stato aderente, con conseguente saldatura tra il concetto di sanzione penale a livello nazionale e quello a livello europeo. In definitiva, il giudice a quo utilizza i criteri Engel per perseguire l’obiettivo dell’applicazione delle tutele predisposte dal diritto nazionale per i soli precetti e per le sole sanzioni che l’ordinamento interno considera, secondo i propri principi, espressione della potestà punitiva penale dello Stato. Ma tale scopo è del tutto diverso da quello che il ricorso ai criteri Engel lascerebbe attendere, cioè l’estensione alla sanzione amministrativa delle sole garanzie convenzionali. Questa contraddittorietà tra premesse ed esito del percorso motivazionale seguito ha determinato – secondo la Consulta – l’inammissibilità della questione. Il giudizio di inammissibilità ha precluso una decisione sul merito di una questione assai delicata, quale quella relativa alla irretroattività delle sanzioni amministrative introdotte dalla legge di depenalizzazione del 2016. Il Giudice delle leggi ha poi dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza le questioni sollevate con riferimento all’art. 3 Cost., in quanto articolate sotto due differenti profili che attengono direttamente alla misura della sanzione amministrativa di nuova introduzione, nonché alla sua esecuzione. Tuttavia, la disposizione a tal fine rilevante, ossia l’art. 3, co. 6, D.Lgs. n. 8 del 2016, non è stata oggetto di censura né della stessa il giudice a quo deve fare applicazione. Per identica ragione, infine, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 27 Cost. A.C.