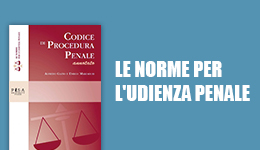Con sentenza n. 95/2019 depositata il 18 aprile scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità - sollevata con ordinanza del 13 luglio 2017 dal Tribunale di Palermo, per asserito contrasto con l’art. 3 Cost. - dell’art. 2, d.lgs. 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, an orma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) nella parte in cui non prevede che la condotta delittuosa ivi descritta sia punibile quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro trentamila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore ad euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila».
Ad avviso del remittente, infatti, la mancanza di soglie di punibilità analoghe a quelle previste dall’art. 3, d.lgs. 74/2000, realizzerebbe una disparità di trattamento arbitraria, essendosi al cospetto di fattispecie sostanzialmente identiche, ormai accomunate dalla struttura bifasica e riconducibili all’unico genus della frode fiscale: atteso che, peraltro, le condotte previste dall’art. 3 esporrebbero il medesimo bene – costituito dall’interesse dell’erario alla piena e rapida percezione dei tributi – a un pericolo concreto «sicuramente eguale», se non addirittura più elevato, rispetto a quello indotto dalle operazioni punite dall’art. 2.
A dimostrazione della sostanziale omogeneità tra le due figure di reato deporrebbero, inoltre: per un verso, il loro rapporto di specialità reciproca dal momento che al nucleo comune di offensività, costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, si aggiungono, in chiave specializzante, da un lato, l’utilizzazione di fatture o di documenti aventi un rilievo probatorio analogo, relativi a operazioni inesistenti (art. 2) e, dall’altro, il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero l’utilizzazione di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento tributario (art. 3); per altro verso, la sovrapposizione tra le operazioni “inesistenti” dell’art. 2 e quelle “simulate” dell’art. 3, la cui distinzione dipenderebbe esclusivamente dalla sussistenza o meno del documento contabile nonché della eventuale copertura cartolare offerta dalla fattura.
Né tantomeno – stando all’ordinanza di remissione - una tale differenza di trattamento risulterebbe giustificata in base alla particolare efficacia probatoria attribuita dalla legislazione tributaria alla fattura o a documento ad essa analogo, non potendosi escludere che il compimento di operazioni simulate e l’impiego di mezzi fraudolenti siano idonei a indurre in errore l’amministrazione finanziaria con il medesimo, se non maggiore, grado di insidiosità dell’uso di fatture per operazioni inesistenti.
Di diverso avviso la Corte Costituzionale la quale, nonostante gli effetti in bonam partem di un eventuale accoglimento della questione connessi ad una contrazione del penalmente rilevante ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 74/2000 - ribadito preliminarmente il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui scelte legislative di questo tipo sono censurabili solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio (ex plurimis, sentenze n. 273 e n. 47 del 2010, ordinanze n. 249 e n. 71 del 2007, nonché, con particolare riguardo al trattamento sanzionatorio, sentenze n. 179 del 2017, n. 236 e n. 148 del 2016), come avviene quando ci si trovi a fronte di diversità di disciplina tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione (tra le altre, sentenze n. 40 del 2019, 35 del 2018, n. 79 e n. 23 del 2016, n. 185 del 2015 e n. 68 del 2012) - esclude ogni censura della “strategia” antifrode adottata dal legislatore che, nel non prevedere soglie e nel punire anche l’emittente ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 74/2000, tiene conto del particolare ruolo della fattura e dei documenti ad essa equiparati sul piano probatorio dalla normativa fiscale nel quadro dell’adempimento degli obblighi del contribuente e della capacità di sviamento dell’attività accertativa degli uffici finanziari, anche in relazione all’attestazione dei eventuali deduzioni o detrazioni in materia di imposte dirette, nonché all’attuazione del principio di neutralità dell’imposta rispetto ai soggetti passivi IVA, mediante il meccanismo della rivalsa e della detrazione. In particolare - come affermato anche dalla più recente giurisprudenza (ex plurimis, tra le ultime, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 15 dicembre 2017, n. 30148; ordinanze 19 ottobre 2018, n. 26453 e 5 luglio 2018, n. 17619) - ogniqualvolta l’ufficio ritenga che la fattura concerne operazioni inesistenti, è su di esso che grava l’onere di provare che l’operazione fatturata non è stata realmente effettuata o che è stata effettuata tra soggetti diversi da quelli in essa indicati.
Peraltro, la differenziazione della disciplina penalistica in ragione della natura del documento su cui ricade la condotta è una costante anche nei delitti di falso, atteso che la falsità in testamento olografo, cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore (art. 491 c.p.) è punita più severamente della generica falsità in (qualsiasi altra) scrittura privata (art. 485 c.p.) ora persino depenalizzata a seguito delle modifiche introdotte col d.lgs. 7/2016.
Nell’art. 2 d.lgs. 74/2000 - prosegue la Corte - il legislatore ha inteso, quindi, far emergere lo speciale disvalore “di azione” che, nel suo apprezzamento – in sé non manifestamente irragionevole – la specifica fattispecie presenta.
D’altro canto, l’affermazione del giudice a quo – stando alla quale le condotte descritte dall’art. 3 potrebbero rappresentare, per la loro particolare insidiosità, un pericolo in concreto sicuramente eguale (se non più elevato) per il bene giuridico rispetto a quelle punite dall’art. 2 – appare in sé apodittica, non essendo accompagnata nell’ordinanza di remissione dal riferimento ad alcuna ipotesi che valga a dimostrare l’assunto; così come costituisce una semplice “opinione personale” la valutazione di eguale o maggiore insidiosità per l’erario delle condotte di cui all’art. 3 d.lgs. 74/2000.
Alla disomogeneità delle fattispecie corrisponde, pertanto, una ragionevole diversità di disciplina, peraltro confermata dal legislatore anche con le riforme del d.l. 138/2011 e del d.lgs. 158/2015 (in particolare con l’eliminazione dell’attenuante speciale dapprima prevista all’art. 2, comma 3, d.lgs. 74/2000), rispetto alla quale la Corte non può che ravvisare, allo stato, una carenza di argomentazione contraria da parte del remittente.