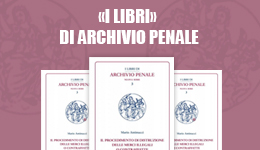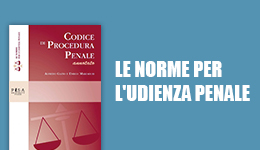Inizialmente il principio di proporzionalità fungeva da meccanismo di autocontenimento del potere statuale. Successivamente, ha assunto il più ambizioso ruolo di custode dei diritti individuali, minacciati dalle ingerenze eccessivamente invasive dell’autorità. Oggi, in un’epoca in cui la separazione dei poteri sembra più un reperto archeologico che un fondamento della democrazia e lo Stato di diritto arranca sotto il peso di inediti assetti costituzionali, la proporzionalità si trasforma in uno strumento creativo nelle mani delle Corti, sempre più ispirate e meno timide nello scrivere, con le proprie decisioni, le regole della vita associata.
Ferma la premessa, la Corte di cassazione non si sottrae al trend.
Nulla quaestio sul fatto che ogni limitazione dei diritti fondamentali in materia di vita privata e familiare, nonché di protezione dei dati personali, debba conformarsi al principio di proporzionalità: ogni restrizione, infatti, è ammissibile quando sia necessaria e rispondente agli interessi generali della comunità (recentemente, Corte giust. UE, Grande Camera, 4 ottobre 2024, causa C-548/21, C.G. contro Bezirkshauptmannschaft Landeck).
Ciò che desta perplessità viene dopo.
La decisione annotata prende le mosse da un caso che vedeva la difesa contestare il rigetto del riesame promosso nell’interesse dell’indagato avverso il decreto di sequestro probatorio e di corrispondenza emesso dal pubblico ministero. La parte privata sollevava un’eccezione di non poco momento: la normativa interna, nella parte in cui consente agli inquirenti di mettere le mani negli archivi digitali dei dispositivi elettronici, sarebbe in contrasto con la direttiva 2016/680/UE. Questa vieta espressamente l’accesso ai dati personali – per ciò che qui interessa, a quelli telefonici – senza il preventivo nulla osta di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente. Qualifica che – è bene dirlo apertamente – non può essere attribuita al pubblico ministero, per quanto questi possa manifestare velleità da arbitro super partes.
A fronte di questi rilievi prende il via una lunga serie di argomentazioni che, pur animate da lodevole impegno ermeneutico, non sempre brillano per coerenza interna. Richiami normativi, equilibrismi interpretativi e qualche salto logico un po’ azzardato finiscono per smarrire quel nitore conclusivo che sarebbe auspicabile trattando di diritti individuali.
E così, si rileva che né la direttiva 2016/680/UE, né il relativo provvedimento di attuazione – il d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 – contengono un espresso riferimento all’attività di raccolta della prova, la quale rimane, pertanto, soggetta alla disciplina generale prevista in materia di ispezione, perquisizione e sequestro. Tuttavia, è stato parimenti evidenziato come la Corte di giustizia abbia esteso l’ambito applicativo della direttiva 2016/680/UE al trattamento dei dati personali conseguente al sequestro, sottolineando l’ampia portata di questa nozione, comprensiva anche del tentativo di accesso alle informazioni utili allo svolgimento di un’indagine penale. Da ciò discende che a tale attività devono ritenersi applicabili i principi di necessità e di proporzionalità del trattamento richiamati dalla direttiva medesima; vi è, inoltre, l’esigenza che l’accesso ai dati sia previamente sottoposto al vaglio di un’autorità giurisdizionale o, comunque, di un organo amministrativo indipendente.
Senza troppi giri di parole, sarebbe bastato dire che si tratta pur sempre di un’ingerenza dell’autorità nella sfera individuale e, proprio per questo, deve essere regolata da norme chiare e prevedibili (principio di legalità) e sottoposta al vaglio di un giudice (riserva di giurisdizione). Entrambi questi presìdi servono a garantire che l’intervento avvenga solo quando strettamente necessario e con modalità proporzionate alle esigenze. Né più, né meno.
La Corte prosegue nel suo ragionamento, interrogandosi se il pubblico ministero possa davvero essere inquadrato come un organo amministrativo indipendente. Esiste un orientamento che aveva riconosciuto questo status nel titolare delle indagini (Cass., Sez. V, 28 gennaio 2025, n. 8376, non mass.). Fortunatamente – e l’avverbio è quanto mai opportuno, specie in un periodo in cui il rapporto tra magistratura giudicante e requirente è al centro del dibattito, anche sotto il profilo (sempreverde) della separazione delle carriere – la decisione in nota prende le giuste distanze: se davvero si volesse intravedere nel pubblico ministero un organo indipendente, ci si troverebbe davanti a un bel cortocircuito: il controllore e il controllato sarebbero ... la stessa persona. In pratica, chi conduce le indagini sarebbe anche chiamato a giudicare se stia facendo tutto secondo le regole, specie quando si tratta di mettere mano ai dati personali.
Tale carenza di terzietà precluderebbe l’effettuazione di un controllo realmente obiettivo ed imparziale sul trattamento dei dati.
Partendo da queste basi, la Corte non ha potuto fare a meno di sottolineare una falla tutt’altro che trascurabile nella normativa interna: non vi è traccia di controlli effettivi sul trattamento dei dati raccolti dopo un sequestro ordinato dal pubblico ministero. Un vuoto normativo che, in materia di diritti fondamentali, pesa eccome.
Escludendo di ricorrere alla categoria dell’inutilizzabilità – atteso che spetta al diritto nazionale, e non a quello unionista, stabilire le regole relative all’ammissibilità e alla valutazione delle prove (Corte giust. UE, 20 aprile 2024, causa C-670/22, Encorchat) – il Supremo Collegio ha ricondotto la fattispecie nell’alveo delle nullità. S’è accorto, infatti, che il contrasto con la normativa europea determina una lesione del diritto di difesa e richiede – come si legge espressamente nell’arresto sul caso Encorchat – di “espungere, nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di una persona sospettata di atti di criminalità, informazioni ed elementi di prova se tale persona non è in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su tali informazioni ed elementi di prova” (p. 131).
La Corte, poi, chiude il cerchio affermando che, sì, aveva ragione il ricorrente nel dire che il vizio sussisteva ma, nonostante la nullità fosse stata effettivamente rilevata, nel caso specifico il diritto della difesa a un vaglio giurisdizionale non risultava leso, dal momento che sul sequestro si era espresso il Tribunale del riesame, interpellato ai sensi dell’art. 324 c.p.p.
Il risultato? Una nullità a geometria variabile o, meglio, un distinguo un po’ forzato tra la natura teorica del vizio (dato dalla frizione tra norma interna e standard europei, con conseguente sacrificio delle garanzie difensive) e la possibilità concreta di farlo valere, ancorata alle peculiarità fattuali e all’equità del singolo caso.
La Corte ha adottato un approccio argomentativo riconducibile alla logica floue: ha, cioè, escluso di ancorare l’invalidità dell’atto alla violazione di una regola predeterminata dal legislatore, secondo uno schema binario rigido, per cui l’atto è valido solo se chi lo compie segue una determinata condotta, e nullo in caso contrario.
L’attenzione si sposta, invece, sullo sviluppo successivo della vicenda processuale, ossia sui comportamenti posti in essere dai vari soggetti coinvolti, i quali potrebbero – secondo la Corte – essere idonei a compensare il pregiudizio subito dalla difesa, contribuendo, così, al ripristino di un’equità complessiva del procedimento.
Eppure, la fattispecie esaminata non sembra rientrare neppure nell’ambito delle sanatorie generali previste dall’art. 183 c.p.p. Nel caso concreto, infatti, l’indagato non ha affatto rinunciato ad eccepire la nullità – come dimostra la stessa esistenza di un ricorso per cassazione a denuncia del vizio – né ha esercitato le facoltà cui l’atto nullo sarebbe preordinato. Del resto, il sequestro disposto dal pubblico ministero non è uno strumento finalizzato al controllo giudiziale, ma piuttosto un atto che viene successivamente sottoposto a verifica, al solo scopo di accertarne la legittimità.
Queste osservazioni mettono in luce una questione cruciale di legalità processuale: la Corte fa dipendere la validità dell’atto da condizioni successive e sviluppa, di fatto, una forma inedita di sanatoria a posteriori, che prende le mosse da un equilibrio rinnovato nei rapporti tra le parti. È evidente, in tal senso, il richiamo alla teoria del pregiudizio effettivo, ossia alla verifica della concreta offensività del vizio in rapporto al valore tutelato dalla disposizione processuale violata (R. Aprati, Effettivo pregiudizio e nullità, Padova, 2018, p. 11).
Per quanto possa apparire funzionale sul piano pragmatico, tale impostazione finisce per entrare in rotta di collisione con il principio costituzionale secondo cui il giusto processo è regolato dalla legge (art. 111, comma 1, Cost.). Non è, quindi, sostenibile una valutazione onnicomprensiva (as a whole test – A. Boldrin, Approccio compensativo e overall fairness nella giurisprudenza della Corte EDU, tra relativismo delle garanzie e altre derive, in Legisl. pen., 26 ottobre 2021, p. 11), che bilanci momenti di svantaggio con elementi di segno favorevole, allo scopo di conferire ex post una parvenza di correttezza al procedimento, purché il suo “equilibrio finale” risulti accettabile.
Una simile impostazione si allontana dal significato autentico del principio di proporzionalità, che – correttamente inteso – ammette la limitazione delle garanzie fondamentali solo in nome di interessi ritenuti preminenti ex lege, ma non ne consente mai la cancellazione o l’azzeramento. Il principio di proporzionalità, proprio per questo, è strettamente connesso a quello di legalità: il bilanciamento tra interessi contrapposti, all’interno del procedimento, deve essere rimesso esclusivamente al legislatore, unico soggetto legittimato a definire ex ante i criteri per la composizione del conflitto, valutando, da un lato, le esigenze collettive legate all’accertamento dei fatti e, dall’altro, le prerogative individuali connesse all’esercizio del diritto di difesa.
La decisione in commento esprime, dunque, un orientamento difficilmente condivisibile, in quanto si inserisce in un percorso di progressivo allontanamento dal principio di legalità, per abbracciare, invece, una visione pragmatica ed efficientista del procedimento penale. Una visione che mal si concilia con l’esigenza di tutela piena e inviolabile delle posizioni soggettive coinvolte, tanto nella fase delle indagini – come nel caso di specie – quanto in quella dibattimentale.
A complicare ulteriormente il quadro vi è il tentativo, da parte della Corte di cassazione, di innestare nell’ordinamento nazionale criteri mutuati dal metodo argomentativo alsaziano per la valutazione di equità: un tentativo che, però, risulta poco convincente, proprio perché non riesce a conciliare la logica del counterbalancing test e la visione olistica del giudizio, con l’irrinunciabile richiamo alla legalità del procedimento, così come sancito dalla nostra Carta costituzionale.
Insomma, ancora una volta la nostra Corte si perde a giocare con le categorie e con i metodi argomentativi di matrice europea: tuttavia, mentre nell’alveo originario tali strumenti sono concepiti per rafforzare le garanzie, una volta oltrepassati i confini nazionali essi vengono piegati a finalità differenti, di natura pragmatica, sotto il segno di un discutibile pseudo-efficientismo. E così, ancora una volta, mentre si consuma questo raffinato esercizio di stile argomentativo, è del tutto trascurato il prezzo che ne paga l’impianto fondamentale del nostro sistema penale.
Contenuti correlati
- Cass., Sez. II, 16 maggio 2025 (ud. 7 maggio 2025), n. 18615 - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
- Proporzionalità della pena e sequestro estorsivo: un coup de théâtre della Corte costituzionale (brevi note a presentazione di Corte cost., sent. 18 luglio 2025, n. 113)
- L’ineffettività dell’obbligo per il P.M. di investigare in favore dell’indagato - Cass., Sez. VI, 3 settembre 2025, (c.c. 4 luglio 2025), n. 30196