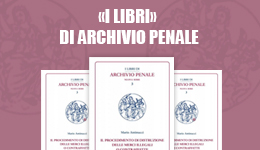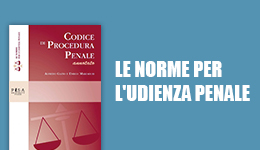1. Le vittime vengono accalappiate online con la prospettiva di un incontro sessuale all’interno di un locale. Dopo l’incontro sono costrette a pagare un non concordato compenso, che varia dai 100 ai 320 euro, sotto la minaccia di rimanere chiuse all’interno del locale. La contestazione riguarda tre imputati che avrebbero commesso il fatto in quattro distinte occasioni.
Privare taluno della libertà personale anche per un tempo breve, ma sufficiente per convincerlo a pagare una prestazione che credeva resa gratuitamente, integra gli estremi del “terribile” reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), punito con la pena detentiva temporanea più elevata del circuito, superiore persino a quella comminata per l’omicidio, al di fuori – pure nella misura minima – del limite di sistema fissata per la reclusione in generale dall’art. 23 c.p.
Né al di sotto del minimo edittale di 25 anni di reclusione si potrebbe in linea di massima scendere, salve le attenuanti, quando gli importi ottenuti come “riscatto” siano di minima entità e quindi il danno patrimoniale causato alla persona offesa sia di «speciale tenuità».
Infatti, questo ordigno sanzionatorio, presente sin dal testo originario del codice Rocco che lo concepiva – come testimoniato dalla sua collocazione topografica – quale speciale delitto contro il patrimonio, nel corso della sua tormentata vita postcostituzionale ha cambiato pelle sino a diventare il più roboante scudo a tutela della persona. Le mutazioni subite dalla norma a partire dagli anni ’70 sono state contrassegnate da progressive impennate sanzionatorie, spintesi sino alla attuale draconiana misura, ma anche dalla definitiva sparizione di qualunque rilievo circa il conseguito intento patrimoniale a carico della vittima, che nel testo originario costituiva l’unica circostanza aggravante del reato.
Si realizzi o non si realizzi la consumazione dell’estorsione – o anche della rapina secondo la denominazione originaria – il colpevole è ora sempre punibile con la reclusione da 25 a 30 anni, semplicemente perché ha privato taluno della libertà personale al precipuo scopo di «conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione». Neppure occorrono altre aggiuntive condotte strumentali, quali la minaccia di mantenere la privazione di libertà, o la richiesta del riscatto (per confronto v. ora art. 289 ter c.p.: sequestro a scopo di coazione, fattispecie più ricca sul piano oggettivo): il modello del reato “a dolo specifico” si spinge nella sua massima virtualità tipizzante, non senza suscitare interrogativi di tenuta costituzionale sul piano della materialità-offensività, invano formulati dalla dottrina, anche e soprattutto alla luce dell’impennata sanzionatoria che il riscontro di quella mera finalità determina rispetto alla molto più contenuta pena della reclusione da sei mesi a otto anni stabilita per il sequestro non qualificato (art. 605 c.p.).
Tipico prodotto dell’isteria legislativa contro i fenomeni criminosi più allarmanti – all’epoca il prosperare dell’“anonima sequestri” che regnava incontrastata con imprese sanguinose capaci scuotere la coscienza dei cittadini italiani – questa mostruosa norma ha mantenuto i suoi eccezionali contrassegni anche dopo il superamento delle ragioni politico-criminali che avevano determinato la sua esondazione dai margini della ragionevolezza e dell’equilibrio sistematico.
Come altre dinamiche economiche, il mercato della penalità ha le sue leggi: una volta impennatesi le “tariffe” a causa di crisi ed emergenze, i prezzi tendono a rimanere gli stessi anche dopo il ritorno alla normalità. Ci sia abitua a tutto, anche a un livello anormale di prezzi e tariffe e questa fisiologica capacità di adattamento nasconde gli eccessi, le discrasie, le soverchierie. Le consegna all’oblio.
Ecco perché le agende politiche non prevedono il riequilibrio, la normalizzazione; prese dall’incombere di nuove emergenze, esibiscono altre “priorità”, dimenticando il passato.
A rispolverare i relitti di queste antiche battaglie contro il crimine ci pensa talvolta la realtà giudiziaria, quando – come nella specie – sul capo di una sgangherata banda di piccoli predatori incombe la pena terribile studiata per sconfiggere niente meno che la “anonima sequestri”.
Non per caso, già qualche anno fu la Corte costituzionale a provare a spuntare gli artigli della norma, avviando con quell’intervento la “fortunata” stagione dell’abbattimento dei imiti edittali previsti dalle comminatorie più elevate, attraverso la messa a disposizione del giudice di una circostanza attenuante per regolare i casi di «lieve entità del fatto», talmente lieve da meritare una pena al di sotto dei minimi eventualmente già ridotti con le attenuanti generiche (Corte cost., 23 marzo 2012, n. 68).
Quei fatti – di sequestro estorsivo, ma anche di rapina, estorsione, sabotaggio militare, pornografia minorile – pur tipici, si pongono alla periferia della sfera applicativa della norma, appena oltre il confine che separa l’illecito dal lecito, e, dato che il minimo edittale è comunque molto elevato e pensato per modalità realizzative ben più gravi e impattanti, occorre consentire al giudice una fuoriuscita dall’ordinario recinto sanzionatorio per rispondere a quell’illecito con una pena adeguata al “disvalore” complessivo da essi espresso.
Se il minimo edittale fosse contenuto nei due anni di reclusione, potrebbe operare la scure dell’art. 131 bis c.p., che consente al giudice di abbattere la pena sino allo “zero”, ma in tali casi, in cui non funziona quella clausola collettiva e comunque una pena “zero” sarebbe ingiustificata, è necessaria ma anche sufficiente la riduzione fino a un terzo. Lo ha già fatto in alcuni casi lo stesso legislatore, lo può fare nei casi a lei sottoposti anche la Corte costituzionale (Corte cost., 2 dicembre 2022, n. 244; Corte cost., 24 maggio 2023, n. 120; Corte cost., 13 maggio 2024, n. 86; Corte cost., 20 maggio 2024, n. 91; Corte cost., 20 giugno 2025, n. 83).
2. Ma torniamo agli sprovveduti sequestratori di cui alla sentenza costituzionale che annotiamo. Il giudice remittente, riconosciuta la lieve entità del fatto da loro commesso e valutata come eccessiva la pena minima che avrebbe dovuto applicare, propone alla Corte di integrare l’intervento già attuato nel 2012, stavolta direttamente abbattendo il minimo edittale e riportandolo alla più contenuta misura (12 anni di reclusione) prevista prima dell’ultima impennata. Ciò sul presupposto che fosse anche problematica l’applicazione dell’attenuante della lieve entità nel caso di specie, in considerazione della pluralità e della ripetitività degli episodi delittuosi e della partecipazione agli stessi di più imputati; che quindi si trattasse di fatto pur lieve sebbene non nel senso dell’attenuante introdotta dalla Corte.
La Corte risponde su questo punto, chiarendo al giudice che nessuno degli elementi da lui evidenziati avrebbe in linea di massima impedito l’applicazione dell’attenuante, per poi tuttavia rilanciare con un primo coup de théâtre: in quel caso, anche se si fosse applicata l’attenuante, la pena finale sarebbe risultata egualmente eccessiva.
Dunque, data questa premessa, sembrava spianata la strada per accogliere la proposta del remittente, intervenendo sui minimi come già successo altre volte, attraverso il principio di proporzionalità, anche in prospettiva “ordinale” pur in assenza di un tertium comparationis.
Ma niente è scontato in questa sorprendente sentenza. Con un nuovo e più sbalorditivo coup de théâtre si opta per una folgorante soluzione, che si nasconde dietro le sembianze di una interpretativa di rigetto.
La Corte non si spinge a adottare la manipolazione suggerita dal remittente, perché deve fargli presente che aveva a disposizione, al più presto, una soluzione molto comoda per aggiustare in concreto una pena altrimenti sproporzionata. La strada maestra era quella di adottare una «interpretazione costituzionalmente conforme» a Costituzione dell’art. 630 c.p., attraverso la quale il denunciato vizio di sproporzione sanzionatoria sarebbe venuto meno.
Questa interpretazione parte proprio dalla misura della pena edittale e in particolare, della pena minima, la quale segnala che il legislatore ha inteso contrastare un fatto particolarmente grave. Da ciò potrà e dovrà presumersi «che il legislatore stesso abbia voluto escludere dal tipo quei fatti concreti che siano connotati da un disvalore assai meno significativo, tale da non giustificare una pena così elevata». Si tratta, invero, di «condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale, collocandosi così in una zona in cui alla "formale” integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano "sostanziale”, l’integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale».
Peraltro, questa espunzione dalla tipicità è agevolmente praticabile – secondo la Corte – «quando la mancata applicazione di una norma penale non comporta l’impunità tout court del fatto, ma semplicemente l’applicazione – in luogo di un reato complesso – delle singole fattispecie criminose che lo compongono, sì da assicurare comunque una risposta adeguata alla gravità del fatto commesso e ragionevolmente dissuasiva, e però contenuta entro i limiti della proporzione».
La conclusione è che «una privazione della libertà personale durata poche decine di minuti finalizzata al conseguimento di un profitto pari a qualche centinaio di euro ben potrà essere ritenuta integrare il comune delitto di sequestro di persona di cui all’art. 605 c. p., sanzionato con la pena minima di sei mesi di reclusione, in concorso con il delitto di estorsione (o se del caso rapina), tentata o consumata». Un carico sanzionatorio ben più proporzionato al «disvalore del fatto».
3. La soluzione adottata dalla Corte con questa interpretativa di rigetto è ben più “innovativa” di quanto sarebbe stata soluzione di accoglimento della questione. Infatti, pur con i limiti performativi delle interpretazioni “suggerite” dalla Corte costituzionale, si tratta di una sentenza che, nel raccogliere a sua volta uno stimolo della giurisprudenza multilivello (Corte giust. UE, Grande Sezione, 8 marzo 2022, C-205/20, NE, su cui F. Viganò, La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell’Unione europea: sull’effetto diretto dell’art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia, in www.sistemapenale.it, 26 aprile 2022), un esprime in pieno lo “spirito del tempo”, nel patrocinare un rapporto diretto tra giudice e pena basato sull’apprezzamento del fatto concreto di reato, relegando solo sullo sfondo la mediazione della legge. Sarà pur sempre un metodo che non impatta con il principio di legalità, come spiega un paragrafo della sentenza, perché attua in senso garantista una interpretazione “riduttiva” basata sulla ratio della legge, ma tale “rassicurazione” non può ignorare che il percorso suggerito al giudice prevede di bypassare il significato univoco delle parole (la «formale integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie») e, sia pure a favore del reo, ignorare il comando legale che attraverso quelle parole – unico mezzo a disposizione del legislatore – è stato impartito al giudice.
Per avvertire la portata dell’innovazione, basta confrontare questa soluzione con i contigui meccanismi correttivi della offensività in concreto e della tenuità del fatto.
Sull’interpretazione conforme che stimola il giudice ad applicare la legge in linea con il principio costituzionale di offensività, si sono registrate diverse sentenze della Corte. Anche in tali casi il fatto sarebbe tipico, a stare alle parole della legge (la «formale integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie»), ma per le particolarità delle conseguenze che ha generato o poteva generare si tratterebbe di un fatto che non crea alcuna offesa al bene giuridico protetto, o comunque crea o può creare un’offesa minima, trascurabile, irrilevante. Attraverso questo meccanismo le parole della legge vengono integrate con una clausola di offensività, che, pur non espressamente («formalmente») prevista, è tuttavia imposta dal principio costituzionale, e dunque fruibile da parte del giudice, sulla base – però – non di un suo personale apprezzamento, bensì di un criterio oggettivo, seppure talvolta – è giusto rilevarlo – non così pacifico e sicuro.
Ad esempio, se un farmacista somministra un farmaco diverso da quello prescritto dal medico commette il reato di cui all’art. 445 c.p., ma se prova che il farmaco era migliore o uguale rispetto a quello prescritto, quanto alla sua efficacia e agli eventuali effetti collaterali, non sarà punito perché il fatto da lui commesso è concretamente inoffensivo. Nel delitto di corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.), posto a tutela del diritto del minore a sviluppare armoniosamente e senza traumi la propria sfera sessuale, se il minore pur fisicamente «presente» non è in grado di percepire con i sensi il compimento dell’atto sessuale a cui lo si vuole «far assistere», perché dorme o perché ha una età tale da non avvertire, in presenza dell’atto, alcun sia pur vago senso di turbamento psichico, eventualmente rielaborabile in età più matura, non c’è alcun pericolo di lesione del bene protetto.
L’elenco potrebbe essere sterminato. Tuttavia, sull’offensività come criterio interpretativo-integrativo, si può discutere in relazione all’esatta individuazione del bene, alla sua portata, alla sua caratura, però, una volta inquadrato l’obiettivo, la soluzione di non punire un fatto tipico ma inoffensivo discende dalle premesse (da ultimo, sull’operatività del principio di offensività in concreto, anche in relazione a reati di pericolo presunto, Corte Cost., 10 luglio 2023, n. 139).
La clausola di tenuità del fatto, nella versione attuale dell’art. 131 bis c.p. non rappresenta un criterio interpretativo-integrativo-correttivo della tipicità, poiché incide solo sulla pena. Il fatto è tipico, offensivo, illecito e colpevolmente realizzato, ma, date le circostanze della sua realizzazione, la capacità a delinquere del reo e ora anche la sua condotta successiva, si tratta di un fatto che non merita alcuna pena. Il comando al giudice viene sterilizzato per volontà dello stesso legislatore, che, peraltro, circonda tale clausola con molte limitazioni operanti già in astratto, che rischiano di contraddire l’operazione avviata nel 2015 con l’inserimento della norma nel codice: prima tra tutte uno sbarramento edittale (ora due anni di pena detentiva minima) costruito sull’inammissibile presunzione per cui la fallacia della legge va riconosciuta solo per rimediare a conseguenze meno gravi, lasciando invece intatte quelle più gravi.
Il meccanismo va ascritto alla vicenda commisurativa e il criterio di giudizio è quello del potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena.
4. Rispetto a questi due meccanismi, che con le loro criticità hanno accompagnato il rapporto tra legge e giudice sino alla sentenza che annotiamo, il potere di “riduzione tipologica” derivante dalla proporzionalità in concreto che la Corte conferisce ora al giudice assume un ruolo distinto e concettualmente autonomo.
Diverge palesemente dalla non applicazione della pena per tenuità del fatto non solo perché la sproporzione sanzionatoria che il giudice rileva concerne limiti edittali particolarmente elevati, ma soprattutto perché incide sulla tipicità, dunque sul reato e non solo sulla pena.
Ma diverge anche dall’inoffensività, che pure esclude il reato, perché in conseguenza del fatto qui il bene è stato offeso; si tratta, tuttavia, di fatto tipico e offensivo, che non merita quel livello sanzionatorio e, dunque, il comando al giudice risulterebbe paralizzato. La dialettica fatto-pena subisce un cortocircuito, tale per cui al giudice non resta che constatare che quel fatto – ad onta del significato letterale delle parole, e quindi della «formale integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie») – in realtà non è tipico (la Corte di giustizia si esprime – ovviamente – in termini di «disapplicazione» del diritto interno che preveda una pena sproporzionata). Quella tipicità si scopre meramente apparente. Sarebbe anche reale solo se la pena comminata fosse molto più bassa, ma essendo così elevata non si può pensare che lo stesso legislatore abbia ragionevolmente deciso di riservarla alla classe di fatti a cui appartiene quello commesso in concreto.
Le parole della legge che descrivono il fatto tradiscono dunque l’intenzione del legislatore e pertanto non sono più vincolanti per il giudice. Stanti questi passaggi, è evidente che siamo al di fuori di una vicenda interpretativa.
La dottrina aveva assunto lo strumento della proporzionalità della pena come criterio interpretativo proponendo casi si finisce per intendere in senso restrittivo una determinata formulazione normativa, espungendovi comportamenti solo apparentemente limitrofi a quello tipologico rientranti nella c.d. “zona grigia” della norma.
Ad esempio, si era segnalata come dettata da proporzionalità in concreto l’interpretazione restrittiva adottata dalla Cassazione a proposito dell’aggravante delle «più persone riunite» nel delitto di estorsione (artt. 628, comma 3, n. 1, e 629, comma 2, c.p.), da intendersi come tutte simultaneamente presenti, a prescindere dalla percezione del soggetto passivo (Cass. Sez. un., 5 giugno 2012, Rv. 252518); o ancora, l’esclusione di ricettazione (art. 648 c.p.) o riciclaggio (art. 648 bis c.p.) da parte dell’avvocato difensore che si fa pagare dal cliente la parcella in contanti e senza emettere la fattura (caso molto discusso nella giurisprudenza tedesca; in Italia, risulta solo GIP Milano, 3 maggio 2024, in Dir. dif., 2024, I, 482); ovvero, l’esclusione della corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) nei confronti di un membro del Parlamento che riceva un’indebita utilità in relazione all'esercizio della sua funzione, non potendosi valutarne la sua condotta in termini di contrarietà o conformità ai doveri d’ufficio (Cass. Sez. VI, 11 settembre 2018, rv. 273791).
Con la svolta impressa dalla Corte costituzionale siamo piuttosto di fronte ad un percorso che conduce alla “sovversione” del segno linguistico e alla sua sostituzione con un “senso” alternativo, seppure risolventesi a favore del reo, cioè in chiave restrittiva della portata “formale” del precetto.
A differenza del criterio dell’offensività in concreto, tuttavia, per compiere questa operazione che la Corte gli rilascia, il giudice non ha altri criteri se non la sua sensibilità e il suo personalissimo bagaglio valutativo circa la sostanziale adeguatezza della pena; il tutto, con la variabile determinante circa l’individuazione della prevalente funzione che la pena dovrebbe esercitare, anch’essa influenzata dalle personali inclinazioni del giudice.
Il potere conferito al giudice dalla Corte costituzionale riguarda inevitabilmente reati puniti con pena elevata, e non è subordinato a limiti o eccezioni.
Seppure è vero che opera in bonam partem, tuttavia questo accesso diretto del giudice alla proporzionalità della risposta sanzionatoria nel caso singolo presenta potenziali ricadute anche in malam partem, ad esempio sulla tenuta del principio di sufficiente determinatezza. Si pensi ad una norma scritta con termini elastici e indeterminati, ma che preveda pene non spropositate (si veda, ad esempio, il caso della bancarotta semplice di cui all’art. 323 c.cr.i., laddove punisce il compimento di operazioni «manifestamente imprudenti» che hanno consumato una «notevole parte» del patrimonio del fallito): poiché nessun eccesso sanzionatorio si determina, il giudice, con gli stessi suoi personali parametri con i quali stabilisce il “disvalore” sostanziale di un fatto, potrà stabilire se quel fatto costituisce reato oppure no, del tutto prescindendo dal significato letterale delle parole la cui ampiezza non lo vincola né lo indirizza. Al contrario del caso del sequestro estorsivo, un basso livello sanzionatorio potrebbe tranquillamente “allentare” l’attenzione del giudice sul tema della «formale integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie», magari spingendolo ad adottare interpretazioni “benintenzionate” che allargano i confini della tipicità, con la complicità di un legislatore non particolarmente allineato sul parametro della determinatezza.
Il giudice, quindi, potrebbe essere indotto a stabilire ogni volta direttamente la pena a suo avviso adeguata e proporzionata al “disvalore” del fatto concreto, per poi trovare in via interpretativa la norma che gli consente di applicarla, così come, in fondo, potrebbe stabilire anche che quel “disvalore” esiste a fonte di una non chiara estensione del significato delle parole della legge.
Nel caso del sequestro estorsivo, l’esclusione della tipicità per eccessività di pena ha trovato la sua ricaduta nella norma generale che punisce il sequestro “base” con pena molto più contenuta. La Corte – come visto – sottolinea che l’operazione di fuoriuscita dalla tipicità del sequestro estorsivo del fatto non gravissimo commesso dagli imputati è resa più agevole dalla circostanza che la mancata applicazione dell’art. 630 c.p. non comporta l’impunità del fatto, ma semplicemente l’applicazione dell’art. 605 c.p., che consente di assicurare comunque una risposta adeguata alla gravità del fatto commesso e ragionevolmente dissuasiva.
In questo modo, l’esclusione di tipicità si risolve in una meno eclatante sostituzione di pena e, in definitiva, in una vicenda commisurativa extraedittale.
E tuttavia la Corte non sembra limitare l’operazione al particolare caso in cui esclusa la tipicità della norma speciale possa subentrare una norma generale dotata di pena più adeguata. Il criterio dovrebbe poter operare anche “in purezza”, non solo in deroga all’art. 15 c.p., quando cioè vi è un’unica norma applicabile, poiché nella sentenza si autorizza l’operazione «in particolare» trattandosi di una sostituzione di pena, non «solo quando» il giudice rinviene una pena più adatta di quella esorbitante.
Solo il tempo ci dirà se questa sentenza rimarrà un unicum legato alla peculiare conformazione del sequestro estorsivo nel nostro codice o se segnerà il consolidarsi di una stagione che promuove il giudice a protagonista principale della scena allestita intorno ai delitti e alle pene, contrassegnata dalla pessima qualità del prodotto legislativo.
Contenuti correlati
- Cass., Sez. II, 16 maggio 2025 (ud. 7 maggio 2025), n. 18615 - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
- Controllo giudiziale sul sequestro del pubblico ministero - Cass., Sez. VI, 8 aprile 2025, n. 13585
- L’ineffettività dell’obbligo per il P.M. di investigare in favore dell’indagato - Cass., Sez. VI, 3 settembre 2025, (c.c. 4 luglio 2025), n. 30196